C’è un nome che, a cinquant’anni dalla morte, continua a risuonare come un enigma e una rivelazione nella storia della musica: Benjamin Britten. Visionario, inquieto, profondo, è stato capace di trasformare l’opera lirica inglese, di toccare con la musica le ferite della guerra, la solitudine, l’innocenza, il mistero del male. Le sue composizioni parlano ancora oggi con forza sorprendente.
Capolavori come Peter Grimes, Il giro di vite, Morte a Venezia, War Requiem sono solo alcune delle tappe di un percorso artistico che attraversa i temi universali dell’esistenza con uno sguardo cristallino e spesso profetico.
In questi giorni, al Teatro Petruzzelli di Bari va in scena The Rape of Lucretia (Il ratto di Lucrezia, dal 18 al 27 aprile), e il 2026 segnerà mezzo secolo dalla scomparsa di Britten: due occasioni preziose per riscoprirlo. Lo facciamo con Alessandro Macchia, storico della musica e romanziere, autore di una nuova biografia (Benjamin Britten. L’uomo, il compositore, l’interprete – EDT, 2024) e del saggio La scorciatoia – Cristianesimo e Personalismo in Benjamin Britten(Galaad Edizioni, 2025), che rivela il legame profondo tra la musica di Britten e la sua visione del mondo, della fede, dell’uomo.
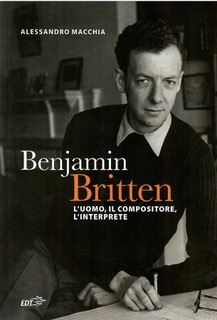
“Con Peter Grimes Britten crea di fatto l’opera lirica inglese – spiega Macchia –. Ma non è un genio nato dal nulla: è un compositore che assorbe il passato, lo metabolizza e lo restituisce con un secondo linguaggio del tutto personale. Nel Novecento, per me, non c’è nessuno della sua statura”.
I temi delle sue opere travalicano la cronaca e la critica sociale. “Britten esplora l’esistenza umana in chiave ampia, direi quasi metafisica”, continua Macchia. Se Peter Grimes è il titolo fondativo, Il giro di vite rappresenta per l’autore “un capolavoro forse ancora superiore”. E accanto alle opere teatrali, Britten ha rinnovato la musica strumentale inglese con composizioni per violoncello dedicate a Rostropovich, considerate da Macchia “le più belle dopo le Suites di Bach”. E poi c’è il lato religioso: “Le Tre parabole scritte per l’esecuzione in chiesa sono l’apice di una tradizione musicale secolare”.
Nel saggio La scorciatoia, Macchia indaga la dimensione spirituale dell’autore, finora poco esplorata. Centrale, in questo percorso, la figura del poeta W. H. Auden. “In un primo studio ne avevo sottovalutato il ruolo, ma rileggendo l’intera opera di Britten mi sono dovuto ricredere: l’influenza di Auden, con la sua visione metafisica e lacerata del mondo, è decisiva. Quando Auden morì, Britten pianse: riconosceva in lui una presenza costante, un’eco profonda di quella lotta tra bene e male che attraversa tutte le sue opere”.
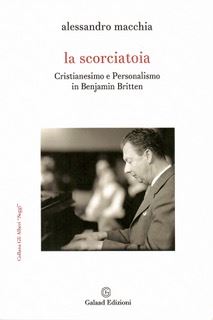
Indissolubile dal nome di Britten è anche quello di Peter Pears, tenore e compagno di vita. “Non era solo un grande interprete – ricorda Macchia – ma un musicista completo, organista e direttore di coro, capace di influenzare le scelte compositive di Britten. In un’epoca in cui l’omosessualità era reato, vissero la loro relazione alla luce del sole, senza censure”.
Infine, il legame con l’infanzia, cui Britten ha dedicato pagine immortali. “Penso a La guida del giovane all’orchestra, esempio didattico insuperato, e alla meno nota ma straordinaria Arca di Noè. Non sono opere minori, ma fondamentali per capire la sua visione: la musica come linguaggio per tutti, ponte tra innocenza e complessità”.
Nel 2026, cinquant’anni dopo la sua scomparsa, Benjamin Britten torna a parlarci. Con voce limpida, inquieta, profondamente umana.
Foto copertina © Wikipedia



