L’iraniano Mohammed Abedini è stato rilasciato domenica dal ministro della Giustizia Carlo Nordio che ha chiesto la revoca della misura cautelare. Accusato di aver esportato componenti elettronici dagli Usa all’Iran rifornendo un’organizzazione terroristica, il suo caso era stato legato dallo stesso ambasciatore iraniano in Italia, Mohammad Reza Sabouri, a quello di Cecilia Sala, la giornalista rilasciata dopo 20 giorni di detenzione in condizioni severe e in assenza di accuse formali, dalla prigione di Evin. Sabouri aveva promesso che le condizioni detentive di Sala in Iran sarebbero state legate in modo reciproco a quelle di Abedini, nonostante al tempo Sala fosse già rinchiusa nella prigione per dissidenti politici dello Stato Islamico di Evin in una cella di isolamento in condizione cosiddette severe e per altro in assenza di accuse formali: dormiva in terra, con la luce sempre accesa e le erano state permesse solo poche brevi telefonate e una visita dell’ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei. Abedini si trovava invece in un carcere comodo da raggiungere, dove era detenuto in condizioni molto migliori, e si era incontrato più volte con il suo avvocato e alcuni diplomatici iraniani.
Molti regimi dittatoriali oggi ricorrono sempre più alla cosiddetta diplomazia degli ostaggi, che rappresenta una delle poche armi a loro disposizione. Alcuni esempi, oltre al caso della giornalista Cecilia Sala? La cestista americana Brittney Griner è stata sequestrata nelle carceri russe, e i cittadini stranieri rastrellati indiscriminatamente in Venezuela, dove governa un brutale dittatura. Persone usate dai regimi come merci di scambio, che segnalano la debolezza di questi regimi. Ne parliamo con Alfredo Luis Somoza, storico, giornalista professionista e scrittore e presidente dal 2003 dell’Istituto Cooperazione Economica Internazionale (ICEI) di Milano che dice: «quanto accaduto a Cecilia Sala, è un sequestro, vero e proprio. L’Italia, si sa, ha sempre negoziato in questi casi durante vari conflitti o situazioni di tensione, come ad esempio, per restare nell’ambito giornalistico, il caso avvento nella capitale irachena nel febbraio di dieci anni fa, quando venne rapita da un’organizzazione della Jihad Islamica la giornalista Giuliana Sgrena. L’Italia ha sempre percorso la via della diplomazia rispetto ad altri paesi più “duri” da questo punto di vista come la Gran Bretagna. Il rischio, endemico in questi casi, ovvero che è così da sempre, è quello di legittimare un’azione ritorsiva come quella iraniana, che ha fatto leva sull’Italia che aveva effettuato un arresto su mandato statunitense. Credo che se non ci fosse stato il “sì” degli Stati Uniti, sarebbe stato molto più difficile risolvere questa vicenda».
Stati Uniti che insieme portano avanti una politica di scambi di ostaggi, come Paesi che neppure si riconoscono tra loro e si aggredisco sia sul piano politico che militare come Israele e Palestina…
«Assolutamente, da quello che sappiamo in queste ore si sta chiudendo la tregua tra Hamas e lo Stato di Israele e l’accordo si basa su il fatto che da una parte saranno restituite le persone sequestrate lo scorso 7 ottobre 2023, e dall’altro lato di prigionieri palestinesi che stanno avendo in Israele le garanzie o i processi secondo le norme di uno Stato democratico e al momento sono incarcerati. Questo è un caso “macro” rispetto a quello di Cecilia Sala, ma il principio della diplomazia dello cambio di ostaggi è esattamente lo stesso».
È quello che sta avvenendo anche tra Russia e Ucraina, e ora la Corea Del Nord alleata di Putin, per dire che questo accade anche in Europa.
«Zelensky ha parlato l’altro giorno, avendo fatto prigionieri dei soldati della Corea del Nord, alleata all’invasore russo, chiedendo a Pyongyang di avviare uno scambio. Anche qui vediamo che la guerra spinge anche l’aggredito a non si parlare di pace, bensì a fare ostaggi da usare come merce di scambio».
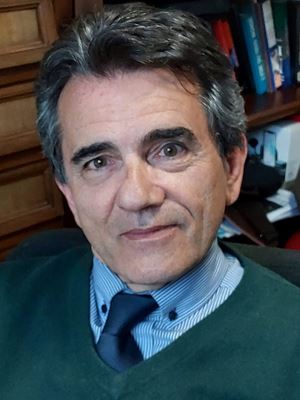
Eppure tra gli arresti dei russi e quelli degli ucraini c’è una disparità di trattamento e umanità come, tornando al caso Sala, quella tra la giornalista italiana detenuta senza imputazione in condizioni severe e senza ai suoi occhiali, e l’ingegnere iraniano in arresto nel carcere di Opera a Milano, raggiungibile in ogni momento dal suo avvocato a cui sono state lasciate le lenti.
«Assolutamente tra regimi e democrazie c’è una differenza per quello che riguarda il trattamento di chi viene detenuto. Però non lo generalizzerei, perché per quanto documentati e raccontabili dal giornalismo, ad esempio, e non silenziati come nei regimi, abbiamo gli Stati Uniti che stanno gestendo un campo offshore di detenzione a Guantanamo, dove i detenuti sono di fatto, persone sequestrate. L’obiettivo delle democrazie, credo, sia quello di togliere legittimità a questo meccanismo».
Che regimi come Iran, Russia o Venezuela usino e spingano sulla diplomazia degli ostaggi, secondo lei non ci dice della loro fragilità? Messi all’angolo da diversi fattori, come le sanzioni internazionali, rispondono con violenza…
«Questa situazione è uno dei sintomi della malattia. La patologia vera e profonda è la mancanza di un ordine nel mondo. Il crollo del multilateralismo, cioè di quei luoghi e Paesi deputati a dirimere i conflitti tra gli Stati, che comprendono anche istanze giuridiche come il Tribunale Internazionale, mostra che queste istituzioni sono sempre meno rispettate e sempre meno autorevoli. Questa assenza garantisce l’impunità a chi sequestra, ricatta, o dichiara guerra».

Oggi invece queste “operazioni” pagano?
«Puoi invadere un paese sovrano, come è successo all’Ucraina, ovvero come ha fatto la Russia, ed essere messo sotto sanzione continuando, abbastanza tranquillamente, a condurre quella guerra senza grandi problemi anche perché quello che non ti dà più l’Europa o gli Stati Uniti lo prendi o vendi in India. Quindi la risposta è sì, queste operazioni pagano. Puoi sequestrare persone e chiedere un riscatto umano come nel caso dell’Iran, puoi invadere un paese e farla franca come nel caso della Russia, puoi fare delle finte elezioni, perderle e e nascondere i verbali e le prove come ha fatto Maduro in Venezuela. Ma puoi fare come Erdogan, che la “fa franca” nonostante quello che da anni sta facendo in Siria con i Kurdi. O come il dittatore della Corea del Nord, che continua a sparare missili sulla testa dei giapponesi e dei sudcoreani».
La fanno franca tutti. Perché?
«Perché da un lato nessuna potenza è in grado di imporre un ordine. Dall’altro lato, le istituzioni multilaterali per prevenire, per perseguire e per punire questo tipo di azioni, sono state totalmente travolte dal discredito e dalla mancanza di fiducia non da parte dei dittatori. Ma anche il fatto che, ad esempio, gli Stati Uniti non abbiano aderito al tribunale penale internazionale: tutti elementi che hanno indebolito quel tipo di distanze sovranazionali e a questo punto la conseguenza è che oggi queste realtà valgono poco».

Soluzioni credibili se ne vedono all’orizzonte? E l’Europa, da questo punto di vista, che ruolo può giocare?
«L’Europa anzitutto è una forza positiva in questo panorama. Ha i problemi che ben conosciamo, per via della sua frammentazione politica, e dovrà decidere cosa fare da grande. Intendo l’esercito e la difesa comuni, ma anche il coordinamento nella politica internazionale. A livello internazionale l’Europa è una presenza sana, e positiva. L’Europa è l’unica, che sta applicando la minimum tax che si è decisa sul lavoro delle multinazionali, e in Europa c’è il gruppo di Paesi che, pur con grande fatica, è il più avanti per quello che riguarda il rispetto del Trattato di Parigi per la mitigazione del cambiamento climatico e la zona della terra con la maggiore uguaglianza davanti allo Stato – dalle forze dell’ordine ai tribunali -, ed è la zona del pianeta con la popolazione più istruita. Un esempio guardato da molti in America Latina».
La speranza allora da dove passa, se di speranza si può parlare?
«La speranza c’è e passa da un pacchetto di riforme. Il mondo ne ha bisogno, ma l’unica persona, l’unico leader mondiale che da sempre sta dicendo di ripristinare il dialogo multilaterale fermando guerre e rapimenti a scopo di ricatto, è Papa Francesco. Dall’inizio del conflitto con l’Ucraina si è speso in prima persona per il negoziato della pace tra l’invasore russo e l’invaso ucraino, ha fatto anche la sua parte nel tentare un avvicinamento degli Stati Uniti con Cuba all’epoca di Barack Obama. Se il Pontefice resta l’unico leader che si espone con vigore, ci sono persone di spessore politico come il presidente brasiliano Lula da Silva che ha proposto una riforma del diritto internazionale e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nel frattempo è importante sostenere la nasciate e il consolidamento di realtà come quella dei Paesi BRIC, Brasile, Russia, India e Cina, con l’aggiunta di Sudafrica, va nel senso di creare un ordine regionale politico, economico e di valori che freni gli Stati-canaglia o le dittature più violente. La speranza è che i casi di ostaggi in aumento, diano a più leader il senso di urgenza di creare un grande movimento di riforma delle istituzioni multilaterali che mettano a tema e affrontino la pace, le disuguaglianze che si allargano tra i ricchi del mondo e i più poveri, e il cambiamento climatico».



